Esodo Pratelli. Dal futurismo al "Novecento" e oltre

Esodo Pratelli, La strada bianca, 1928, olio su tavola, cm. 50x59
Dal 16 Aprile 2025 al 13 Maggio 2025
Milano
Luogo: Centro Culturale di Milano
Indirizzo: Largo Corsia dei Servi 4
Orari: da lun a ven 10 – 13 / 14:30 – 18; sab e dom 15 – 19 Chiuso domenica 20 aprile S. Pasqua Apertura speciale lunedì 21 aprile Pasquetta 14:30 – 18
Curatori: Elena Pontiggia
Costo del biglietto: ingresso gratuito
Telefono per informazioni: +39 02 86455162
Sito ufficiale: http://www.centroculturaledimilano.it
ande restrospettiva dedicata all’artista e intitolata Esodo Pratelli. Dal futurismo al “Novecento” e oltre, curata da Elena Pontiggia, è esposta dal 17 aprile al 13 maggio presso il CMC Centro Culturale di Milano, con un corpus di circa cinquanta opere, che tracciano l’intenso percorso di una figura di spicco della pittura italiana della prima metà del ‘900.
La mostra ripercorre con andamento cronologico le fasi artistiche che hanno caratterizzato il lavoro di Esodo Pratelli da un’iniziale espressione legata al realismo e più marcatamente al simbolismo, con la realizzazione di opere pittoriche e di maioliche policrome, per poi evolvere nel primo decennio del ‘900 all’adesione al movimento futurista e approdare negli anni Venti al Novecento Italiano. Nella sua ricerca ha rivolto l’attenzione a numerose tecniche dalla pittura a olio all’acquerello, dall’uso della tempera al carboncino, fino ad arrivare alla lavorazione della ceramica e alla realizzazione di arazzi, il cui impiego ha evidenziato una spiccata poliedricità.
Una vita molto intensa, intrisa di una fervida cultura legata al contesto familiare, coltivata grazie a viaggi, permanenze a Parigi, a Roma, oltre a incontri e contatti con importanti esponenti dell’epoca fra cui Boccioni, Carrà, Severini, Marinetti, Gris, Delaunay, Sironi.
Pratelli partecipa attivamente alle iniziative del suo tempo, si ricordano infatti la collaborazione alla nascita della Corporazione delle Arti Plastiche (1923), la docenza e la direzione a Milano della Scuola d’Arte Applicata del Castello Sforzesco (1924 ca. – 1934), la proposta firmata con Sironi, Sarfatti, Funi, Carrà per l’istituzione di un Consiglio superiore per l’arte moderna (1925), la nomina a segretario del Sindacato Fascista Belle Arti di Milano (1927) e l’anno successivo della Lombardia. Decenni molto densi in cui l’artista si è dedicato anche alla creazione di bozzetti per scenografie e costumi di opere liriche, durante i quali non sono mancati momenti di allontanamento dalla pittura, tra il 1935 e il 1950, anni che lo vedono protagonista a Roma, con un’intensa attività in ambito cinematografico, come sceneggiatore e regista.
Un aspetto che contraddistingue la pittura di Pratelli si ritrova nella costante presenza della natura, seppur con declinazioni diverse a seconda della fase artistica nella quale è immerso. Anche nelle tele dove il paesaggio non è il soggetto protagonista, l’elemento naturale emerge in maniera preponderante, cattura l’attenzione e appare carico di significati. Talvolta si tratta di agenti atmosferici, che l’uomo non può controllare e che appaiono ancor più catalizzanti all’interno delle opere. L’attenzione al segno e alla linearità, accanto alla raffinatezza e all’eleganza del tratto, i toni morbidi e leggeri sono ulteriori caratteri distintivi del lavoro dell’artista, conservati nel corso di tutta la sua carriera. Importanti i maestri cui si è ispirato e ha fatto riferimento nel tempo, da Klimt a Beardsley durante al giovinezza, da Carrà a Sironi in età più matura.
Nell’approfondito testo in catalogo afferma la curatrice Elena Pontiggia in relazione alla sua pittura: “Merita di essere conosciuta per l’intensità di tanti suoi esiti, ma anche per l’esprit de finesse che la percorre. I suoi colori delicati, le sue raffinate composizioni di figure, i suoi temi confidenziali, i suoi paesaggi urbani e i suoi paesaggi senza aggettivi, tutta la sua traiettoria stilistica, insomma, dal simbolismo al futurismo al “Novecento”, cui vanno aggiunti i suoi ultimi decenni tutt’altro che senili, hanno troppo valore per essere relegati nella Scatola delle cose dimenticate, come l’artista intitola un quadro del 1967, che è anche una trasparente metafora della sua vicenda espressiva”.
Nel percorso espositivo fra i lavori degli esordi è presente la maiolica policroma Estate nella notte (1911), citata e descritta nel carteggio con il cugino Balilla Pratella; con lui coltiva un profondo rapporto epistolare nel corso di tutta la sua vita. All’interno della lettera, l’artista oltre a dichiararsi ceramista descrive gli intenti di quel momento facendo emergere il suo interesse per il simbolo e gli elementi naturali.
Del periodo futurista, dettato dall’interesse per il movimento, delle linee che tendono alla verticalità e a colori più vivaci, si ammirano le tele Frammento della primavera (1913), caratterizzato dal roteare di segmenti in gran parte circolari e i bozzetti per le scene e i costumi dell’opera lirica del cugino Balilla dal titolo L’aviatore Dro (1913). Si tratta della sua prima progettazione scenografica ufficialmente futurista, eseguita per la prima volta nel 1920, nella quale, sia che si tratti di scene sia di figurini, si avverte la predilezione per la sintesi, per una linearità ondulata del tratto e di una tensione verso l’infinito.
In linea con il suo avvicinamento al Novecento italiano l’artista volge a delle rappresentazioni in cui emerge la ricerca di una moderna classicità, dove la plasticità, i volumi, la nitidezza delle forme e la supremazia del disegno sul colore assumono un ruolo centrale. Lo si osserva in Maternità (1922) e nel ritratto della figlia Lilia (1925); qui i soggetti dominano la scena con una solida volumetria, una forma precisa e nitida. In questi anni frequenta Mario Sironi, al quale dedica Ritratto di Sironi (1928); con lui condivide l’interesse per la pittura solida, monumentale e viene influenzato nella scelta di soggetti quali cantieri, fabbriche, periferie, ne è esempio Ciminiere (1924).
Sono inoltre in mostra lavori che attestano il successivo allontanamento dal movimento del Novecento italiano verso un maggior interesse per i paesaggi, per una dimensione quotidiana, casalinga, orientata a una visione più serena e cromaticamente più luminosa, in cui predomina la grandezza della natura. Estate (1930) e La favola del bosco (1931), con ambientazioni quasi fiabesche e legate alla vita di tutti i giorni, con scene intime e tenere, ben rappresentano questa inversione di rotta e l’avvicinamento al realismo magico.
Anche nelle opere degli anni Cinquanta, fra le altre Gatto sulla stufa (1957), successive all’isolamento dal mondo pittorico, i temi sono familiari, fino ad arrivare agli anni Sessanta dove la figurazione è legata a particolari, sempre del quotidiano, ma ancor più intimi e quasi nascosti; come nell’emblematica La scatola delle cose dimenticate (1967).
Accompagna la mostra un’importante e dettagliata monografia di Elena Pontiggia, edita da Silvana Editoriale, ad oggi la più completa sull’artista, che traccia un esaustivo ritratto di Esodo Pratelli e del suo lavoro. Accanto alle numerose tavole a colori, oltre un centinaio, sono pubblicati carteggi inediti dell’artista con personalità a lui vicine nel suo percorso di vita e in quello artistico.
Esodo Pratelli (1892 – 1983) nasce a Lugo -Ravenna- dove frequenta il ginnasio e la Scuola di Disegno e Plastica, vince il concorso e la borsa di studio, quindi si trasferisce a Roma. Formatosi all’Accademia di Via Ripetta a Roma, dopo un'iniziale adesione al simbolismo, si avvicina nel 1913 - 1914 al futurismo, entrando in contatto con i maggiori esponenti del movimento durante il suo soggiorno a Parigi. Si dedica alla realizzazione di tele, ceramiche e contemporaneamente scenografie e costumi per L’Aviatore Dro, opera del cugino Balilla Pratella, in stile pienamente futurista. Nel 1915 è richiamato alle armi da cui sarà congedato solo nel 1919, quando a guerra conclusa si stabilisce a Milano. Negli anni Venti è nominato segretario del Sindacato Fascista Belle Arti di Milano e successivamente della Lombardia. Si sposa con Elsa Martina e dal loro matrimonio nel 1922, nasce la figlia Lilia e successivamente, nel 1928, il figlio Giuliano. Aderisce al Novecento Italiano ed è annoverato da Margherita Sarfatti nel “vivaio di giovani forze” del movimento; partecipa nel 1926 alla I Mostra del Novecento Italiano alla Permanente di Milano e a tutte le esposizioni successive in Italia e all’estero. Anni significativi sono il 1927 e il 1928 grazie alla presenza alla Biennale di Brera, con le opere Giulia e Laura e Paese toscano, e per la prima volta alla XVI Biennale di Venezia, dove tornerà ad esporre nel ‘30, ‘32 e ‘34. Nel 1931 è tra gli artisti della I Quadriennale e nello stesso anno alla Exhibition of Contemporary Italian Painting, organizzata dalla Quadriennale di Roma al Museo di Baltimora. Il 28 ottobre 1932 nel decennale della marcia su Roma si apre a Palazzo delle Esposizioni la Mostra della Rivoluzione Fascista, per cui Pratelli si occupa della parte artistica di tre sale.
Nel 1935 lascia Milano per tornare a Roma, dove si dedica alla scenografia e regia cinematografica, abbandonando sia l’insegnamento che l’attività espositiva. Nella seconda metà degli anni Cinquanta riprende l’attività pittorica, che continua fino agli ultimi anni della sua vita trascorsi a Roma.
Attualmente importanti opere dell’artista sono custodite in musei nazionali e internazionali, gallerie e collezioni pubbliche e private.
Si ringrazia la Fondazione Massimo e Sonia Cirulli per il significativo prestito.
Inaugurazione mercoledì 16 aprile, ore 18
La mostra ripercorre con andamento cronologico le fasi artistiche che hanno caratterizzato il lavoro di Esodo Pratelli da un’iniziale espressione legata al realismo e più marcatamente al simbolismo, con la realizzazione di opere pittoriche e di maioliche policrome, per poi evolvere nel primo decennio del ‘900 all’adesione al movimento futurista e approdare negli anni Venti al Novecento Italiano. Nella sua ricerca ha rivolto l’attenzione a numerose tecniche dalla pittura a olio all’acquerello, dall’uso della tempera al carboncino, fino ad arrivare alla lavorazione della ceramica e alla realizzazione di arazzi, il cui impiego ha evidenziato una spiccata poliedricità.
Una vita molto intensa, intrisa di una fervida cultura legata al contesto familiare, coltivata grazie a viaggi, permanenze a Parigi, a Roma, oltre a incontri e contatti con importanti esponenti dell’epoca fra cui Boccioni, Carrà, Severini, Marinetti, Gris, Delaunay, Sironi.
Pratelli partecipa attivamente alle iniziative del suo tempo, si ricordano infatti la collaborazione alla nascita della Corporazione delle Arti Plastiche (1923), la docenza e la direzione a Milano della Scuola d’Arte Applicata del Castello Sforzesco (1924 ca. – 1934), la proposta firmata con Sironi, Sarfatti, Funi, Carrà per l’istituzione di un Consiglio superiore per l’arte moderna (1925), la nomina a segretario del Sindacato Fascista Belle Arti di Milano (1927) e l’anno successivo della Lombardia. Decenni molto densi in cui l’artista si è dedicato anche alla creazione di bozzetti per scenografie e costumi di opere liriche, durante i quali non sono mancati momenti di allontanamento dalla pittura, tra il 1935 e il 1950, anni che lo vedono protagonista a Roma, con un’intensa attività in ambito cinematografico, come sceneggiatore e regista.
Un aspetto che contraddistingue la pittura di Pratelli si ritrova nella costante presenza della natura, seppur con declinazioni diverse a seconda della fase artistica nella quale è immerso. Anche nelle tele dove il paesaggio non è il soggetto protagonista, l’elemento naturale emerge in maniera preponderante, cattura l’attenzione e appare carico di significati. Talvolta si tratta di agenti atmosferici, che l’uomo non può controllare e che appaiono ancor più catalizzanti all’interno delle opere. L’attenzione al segno e alla linearità, accanto alla raffinatezza e all’eleganza del tratto, i toni morbidi e leggeri sono ulteriori caratteri distintivi del lavoro dell’artista, conservati nel corso di tutta la sua carriera. Importanti i maestri cui si è ispirato e ha fatto riferimento nel tempo, da Klimt a Beardsley durante al giovinezza, da Carrà a Sironi in età più matura.
Nell’approfondito testo in catalogo afferma la curatrice Elena Pontiggia in relazione alla sua pittura: “Merita di essere conosciuta per l’intensità di tanti suoi esiti, ma anche per l’esprit de finesse che la percorre. I suoi colori delicati, le sue raffinate composizioni di figure, i suoi temi confidenziali, i suoi paesaggi urbani e i suoi paesaggi senza aggettivi, tutta la sua traiettoria stilistica, insomma, dal simbolismo al futurismo al “Novecento”, cui vanno aggiunti i suoi ultimi decenni tutt’altro che senili, hanno troppo valore per essere relegati nella Scatola delle cose dimenticate, come l’artista intitola un quadro del 1967, che è anche una trasparente metafora della sua vicenda espressiva”.
Nel percorso espositivo fra i lavori degli esordi è presente la maiolica policroma Estate nella notte (1911), citata e descritta nel carteggio con il cugino Balilla Pratella; con lui coltiva un profondo rapporto epistolare nel corso di tutta la sua vita. All’interno della lettera, l’artista oltre a dichiararsi ceramista descrive gli intenti di quel momento facendo emergere il suo interesse per il simbolo e gli elementi naturali.
Del periodo futurista, dettato dall’interesse per il movimento, delle linee che tendono alla verticalità e a colori più vivaci, si ammirano le tele Frammento della primavera (1913), caratterizzato dal roteare di segmenti in gran parte circolari e i bozzetti per le scene e i costumi dell’opera lirica del cugino Balilla dal titolo L’aviatore Dro (1913). Si tratta della sua prima progettazione scenografica ufficialmente futurista, eseguita per la prima volta nel 1920, nella quale, sia che si tratti di scene sia di figurini, si avverte la predilezione per la sintesi, per una linearità ondulata del tratto e di una tensione verso l’infinito.
In linea con il suo avvicinamento al Novecento italiano l’artista volge a delle rappresentazioni in cui emerge la ricerca di una moderna classicità, dove la plasticità, i volumi, la nitidezza delle forme e la supremazia del disegno sul colore assumono un ruolo centrale. Lo si osserva in Maternità (1922) e nel ritratto della figlia Lilia (1925); qui i soggetti dominano la scena con una solida volumetria, una forma precisa e nitida. In questi anni frequenta Mario Sironi, al quale dedica Ritratto di Sironi (1928); con lui condivide l’interesse per la pittura solida, monumentale e viene influenzato nella scelta di soggetti quali cantieri, fabbriche, periferie, ne è esempio Ciminiere (1924).
Sono inoltre in mostra lavori che attestano il successivo allontanamento dal movimento del Novecento italiano verso un maggior interesse per i paesaggi, per una dimensione quotidiana, casalinga, orientata a una visione più serena e cromaticamente più luminosa, in cui predomina la grandezza della natura. Estate (1930) e La favola del bosco (1931), con ambientazioni quasi fiabesche e legate alla vita di tutti i giorni, con scene intime e tenere, ben rappresentano questa inversione di rotta e l’avvicinamento al realismo magico.
Anche nelle opere degli anni Cinquanta, fra le altre Gatto sulla stufa (1957), successive all’isolamento dal mondo pittorico, i temi sono familiari, fino ad arrivare agli anni Sessanta dove la figurazione è legata a particolari, sempre del quotidiano, ma ancor più intimi e quasi nascosti; come nell’emblematica La scatola delle cose dimenticate (1967).
Accompagna la mostra un’importante e dettagliata monografia di Elena Pontiggia, edita da Silvana Editoriale, ad oggi la più completa sull’artista, che traccia un esaustivo ritratto di Esodo Pratelli e del suo lavoro. Accanto alle numerose tavole a colori, oltre un centinaio, sono pubblicati carteggi inediti dell’artista con personalità a lui vicine nel suo percorso di vita e in quello artistico.
Esodo Pratelli (1892 – 1983) nasce a Lugo -Ravenna- dove frequenta il ginnasio e la Scuola di Disegno e Plastica, vince il concorso e la borsa di studio, quindi si trasferisce a Roma. Formatosi all’Accademia di Via Ripetta a Roma, dopo un'iniziale adesione al simbolismo, si avvicina nel 1913 - 1914 al futurismo, entrando in contatto con i maggiori esponenti del movimento durante il suo soggiorno a Parigi. Si dedica alla realizzazione di tele, ceramiche e contemporaneamente scenografie e costumi per L’Aviatore Dro, opera del cugino Balilla Pratella, in stile pienamente futurista. Nel 1915 è richiamato alle armi da cui sarà congedato solo nel 1919, quando a guerra conclusa si stabilisce a Milano. Negli anni Venti è nominato segretario del Sindacato Fascista Belle Arti di Milano e successivamente della Lombardia. Si sposa con Elsa Martina e dal loro matrimonio nel 1922, nasce la figlia Lilia e successivamente, nel 1928, il figlio Giuliano. Aderisce al Novecento Italiano ed è annoverato da Margherita Sarfatti nel “vivaio di giovani forze” del movimento; partecipa nel 1926 alla I Mostra del Novecento Italiano alla Permanente di Milano e a tutte le esposizioni successive in Italia e all’estero. Anni significativi sono il 1927 e il 1928 grazie alla presenza alla Biennale di Brera, con le opere Giulia e Laura e Paese toscano, e per la prima volta alla XVI Biennale di Venezia, dove tornerà ad esporre nel ‘30, ‘32 e ‘34. Nel 1931 è tra gli artisti della I Quadriennale e nello stesso anno alla Exhibition of Contemporary Italian Painting, organizzata dalla Quadriennale di Roma al Museo di Baltimora. Il 28 ottobre 1932 nel decennale della marcia su Roma si apre a Palazzo delle Esposizioni la Mostra della Rivoluzione Fascista, per cui Pratelli si occupa della parte artistica di tre sale.
Nel 1935 lascia Milano per tornare a Roma, dove si dedica alla scenografia e regia cinematografica, abbandonando sia l’insegnamento che l’attività espositiva. Nella seconda metà degli anni Cinquanta riprende l’attività pittorica, che continua fino agli ultimi anni della sua vita trascorsi a Roma.
Attualmente importanti opere dell’artista sono custodite in musei nazionali e internazionali, gallerie e collezioni pubbliche e private.
Si ringrazia la Fondazione Massimo e Sonia Cirulli per il significativo prestito.
Inaugurazione mercoledì 16 aprile, ore 18
SCARICA IL COMUNICATO IN PDF
COMMENTI

-
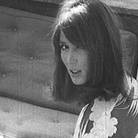 Dal 16 aprile 2025 al 07 settembre 2025
Torino | GAM – Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea
Dal 16 aprile 2025 al 07 settembre 2025
Torino | GAM – Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea
Giosetta Fioroni
-
 Dal 16 aprile 2025 al 29 giugno 2025
Terni | Palazzo Montani Leoni
Dal 16 aprile 2025 al 29 giugno 2025
Terni | Palazzo Montani Leoni
Da Degas a Boldini. Uno sguardo sull'Impressionismo tra Francia e Italia
-
 Dal 17 aprile 2025 al 27 luglio 2025
Torino | Sale Chiablese - Musei Reali di Torino
Dal 17 aprile 2025 al 27 luglio 2025
Torino | Sale Chiablese - Musei Reali di Torino
DA BOTTICELLI A MUCHA. Bellezza, Natura, Seduzione
-
 Dal 10 aprile 2025 al 07 settembre 2025
Venaria Reale | Reggia di Venaria
Dal 10 aprile 2025 al 07 settembre 2025
Venaria Reale | Reggia di Venaria
Magnifiche collezioni. Arte e potere nella Genova dei Dogi
-
 Dal 12 aprile 2025 al 15 giugno 2025
Mantova | Palazzo Ducale
Dal 12 aprile 2025 al 15 giugno 2025
Mantova | Palazzo Ducale
Mantegna vs Mantegna. Tra luce e ombra: la Camera Picta e il San Sebastiano di Ca’ d’Oro
-
 Dal 13 aprile 2025 al 26 ottobre 2025
Ragusa | Palazzo Garofalo
Dal 13 aprile 2025 al 26 ottobre 2025
Ragusa | Palazzo Garofalo
Gli Egizi e i doni del Nilo


