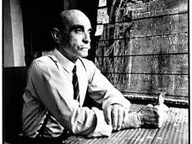Visitabili il 22 e il 23 settembre le tombe di Fadilla e dei Nasoni
Dopo 15 anni riaprono i Mausolei di Saxa Rubra

Tomba di Fadilla, Courtesy Soprintendenza Speciale di Roma
Francesca Grego
19/09/2018
Roma - Sono rimaste chiuse per 15 anni le Tombe di Fadilla e dei Nasoni, due eleganti mausolei di età imperiale scavati nel tufo sulla via Flaminia, a Nord della Capitale. Il tempo, le infiltrazioni d’acqua e le spoliazioni ripetute ne avevano intaccato l’antica bellezza.
Dopo il restauro a cura della Soprintendenza di Roma, sono finalmente pronti ad accogliere il pubblico in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio in programma per sabato 22 e domenica 23 settembre.
Nel loro futuro, un ampio progetto di valorizzazione dell’area, che negli ultimi 20 anni ha restituito tesori archeologici come la Tomba di Macrino (nota anche come “Tomba del Gladiatore”), le testimonianze della battaglia di Ponte Milvio, la fonte di Anna Perenna, la villa di via Tortora e, in tempi recentissimi, un edificio tardo antico decorato con pregevoli mosaici, che è ancora oggetto di indagini.
Scoperte che vanno ad aggiungersi alla Villa di Livia a Prima Porta, luogo dell’otium dell’imperatore Augusto, all’Arco di Malborghetto e ai Mausolei di Saxa Rubra.
Tra questi, le Tombe dei Nasoni e di Fadilla spiccano come rare testimonianze della Roma di età antoniniana, il momento di massima espansione dell’Impero.
Preziose decorazioni ornano gli interni di entrambe, che si distinguono per l’aspetto e per le vicissitudini attraversate nel corso del tempo.
Piccola e incredibilmente ben conservata, la Tomba di Fadilla ha accolto le spoglie di una nobildonna della famiglia degli Antonini. Su tre pareti ospita tombe ad arcosolio (nicchie scavate e sormontate da un arco, in cui venivano deposti i sarcofagi), mentre il pavimento mosaicato sfoggia raffinati pattern geometrici bianchi e neri. Delicate pitture murali ricoprono i muri e la volta con motivi floreali, pavoni, geni alati, volti di fanciulli e personificazioni delle stagioni.
Scoperta alla fine del Seicento, la Tomba dei Nasoni ha una storia travagliata. Fin da subito andò incontro a importanti spoliazioni: papa Clemente X consentì infatti a suo nipote di appropriarsi di diverse porzioni di affreschi che servirono per adornare la sua villa sull’Esquilino. Il pubblico attuale potrà farsene un’idea grazie ai pannelli realizzati a partire dalle tavole del pittore e incisore Pietro Santi Bartoli, che ritrasse le decorazioni della tomba subito dopo il suo ritrovamento.
Grazie a questa documentazione sappiamo anche che il sepolcro presentava una facciata esterna in marmo a forma di tempietto, oggi scomparsa, le cui iscrizioni hanno permesso di attribuirne la proprietà ai Nasoni, la stirpe del poeta Ovidio. Un’altra certezza è che la conformazione del terreno circostante sia profondamente mutata nei secoli, a causa di una cava di tufo che ha eroso la collina originaria agevolando le infiltrazioni d’acqua all’interno del mausoleo.
Entrando oggi possiamo vedere un ambiente rettangolare con volta a botte, con sette nicchie per le sepolture e un articolato apparato decorativo, che ne fanno un monumento di notevole importanza. Sulle pareti, pitture di grandi dimensioni mostrano i luoghi di beatitudine che attendono i defunti, attorniati da mostri marini e vittorie alate, mentre sul soffitto sopravvive una rappresentazione del Giudizio di Paride. Originariamente questa faceva parte di un ciclo narrativo sulla Guerra di Troia, che gli antichi consideravano un’allegoria della vita umana, fatta di vittorie e di sconfitte. Sulla parete in fondo, infine, possiamo solo immaginare le scene di Edipo e la Sfinge insieme a Pegaso affiancato da due ninfe.
Leggi anche:
• Sogno di fine estate: Caracalla by night
• La storia in 3D: le Terme di Diocleziano com’erano nel IV secolo
Dopo il restauro a cura della Soprintendenza di Roma, sono finalmente pronti ad accogliere il pubblico in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio in programma per sabato 22 e domenica 23 settembre.
Nel loro futuro, un ampio progetto di valorizzazione dell’area, che negli ultimi 20 anni ha restituito tesori archeologici come la Tomba di Macrino (nota anche come “Tomba del Gladiatore”), le testimonianze della battaglia di Ponte Milvio, la fonte di Anna Perenna, la villa di via Tortora e, in tempi recentissimi, un edificio tardo antico decorato con pregevoli mosaici, che è ancora oggetto di indagini.
Scoperte che vanno ad aggiungersi alla Villa di Livia a Prima Porta, luogo dell’otium dell’imperatore Augusto, all’Arco di Malborghetto e ai Mausolei di Saxa Rubra.
Tra questi, le Tombe dei Nasoni e di Fadilla spiccano come rare testimonianze della Roma di età antoniniana, il momento di massima espansione dell’Impero.
Preziose decorazioni ornano gli interni di entrambe, che si distinguono per l’aspetto e per le vicissitudini attraversate nel corso del tempo.
Piccola e incredibilmente ben conservata, la Tomba di Fadilla ha accolto le spoglie di una nobildonna della famiglia degli Antonini. Su tre pareti ospita tombe ad arcosolio (nicchie scavate e sormontate da un arco, in cui venivano deposti i sarcofagi), mentre il pavimento mosaicato sfoggia raffinati pattern geometrici bianchi e neri. Delicate pitture murali ricoprono i muri e la volta con motivi floreali, pavoni, geni alati, volti di fanciulli e personificazioni delle stagioni.
Scoperta alla fine del Seicento, la Tomba dei Nasoni ha una storia travagliata. Fin da subito andò incontro a importanti spoliazioni: papa Clemente X consentì infatti a suo nipote di appropriarsi di diverse porzioni di affreschi che servirono per adornare la sua villa sull’Esquilino. Il pubblico attuale potrà farsene un’idea grazie ai pannelli realizzati a partire dalle tavole del pittore e incisore Pietro Santi Bartoli, che ritrasse le decorazioni della tomba subito dopo il suo ritrovamento.
Grazie a questa documentazione sappiamo anche che il sepolcro presentava una facciata esterna in marmo a forma di tempietto, oggi scomparsa, le cui iscrizioni hanno permesso di attribuirne la proprietà ai Nasoni, la stirpe del poeta Ovidio. Un’altra certezza è che la conformazione del terreno circostante sia profondamente mutata nei secoli, a causa di una cava di tufo che ha eroso la collina originaria agevolando le infiltrazioni d’acqua all’interno del mausoleo.
Entrando oggi possiamo vedere un ambiente rettangolare con volta a botte, con sette nicchie per le sepolture e un articolato apparato decorativo, che ne fanno un monumento di notevole importanza. Sulle pareti, pitture di grandi dimensioni mostrano i luoghi di beatitudine che attendono i defunti, attorniati da mostri marini e vittorie alate, mentre sul soffitto sopravvive una rappresentazione del Giudizio di Paride. Originariamente questa faceva parte di un ciclo narrativo sulla Guerra di Troia, che gli antichi consideravano un’allegoria della vita umana, fatta di vittorie e di sconfitte. Sulla parete in fondo, infine, possiamo solo immaginare le scene di Edipo e la Sfinge insieme a Pegaso affiancato da due ninfe.
Leggi anche:
• Sogno di fine estate: Caracalla by night
• La storia in 3D: le Terme di Diocleziano com’erano nel IV secolo
LA MAPPA
NOTIZIE
VEDI ANCHE
-
 Napoli | A Villa Campolieto dal 28 marzo al 31 dicembre 2025
Napoli | A Villa Campolieto dal 28 marzo al 31 dicembre 2025
Dall’uovo alle mele, i piaceri della tavola nell’antica Ercolano
-
 Roma | Dal 28 marzo al 12 ottobre al Museo di Roma di Palazzo Braschi
Roma | Dal 28 marzo al 12 ottobre al Museo di Roma di Palazzo Braschi
Yoshitaka Amano a Roma con oltre 200 opere
-
 Perugia | Dal 18 aprile al 6 luglio a Palazzo della Penna – Centro per le Arti Contemporanee
Perugia | Dal 18 aprile al 6 luglio a Palazzo della Penna – Centro per le Arti Contemporanee
A Perugia l'alfabeto senza parole di Afro, Burri, Capogrossi
-
 Roma | Dal 4 aprile al 13 luglio 2025
Roma | Dal 4 aprile al 13 luglio 2025
Barocco globale: la Roma cosmopolita di Bernini in mostra alle Scuderie del Quirinale
-
 Roma | A Roma dal 17 aprile al 14 settembre
Roma | A Roma dal 17 aprile al 14 settembre
Al Museo Bilotti il mito e il sacro sotto la lente dell'arte contemporanea
-
 Roma | Dall’11 aprile al 14 settembre
Roma | Dall’11 aprile al 14 settembre
Nino Bertoletti, Carlo Levi, Piero Martina in mostra nel centenario della Galleria d’Arte Moderna di Roma